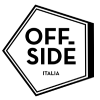Ancor più dei Balcani e del Caucaso, il Medio Oriente rappresenta e ha rappresentato – almeno nell’ultimo mezzo secolo, se non di più – il vero termometro politico della geopolitca mondiale dove si poteva testare lo stato di salute delle super-potenze mondiali e allo stesso tempo constatare le velleità degli attori locali tra ambizioni di grandezza e frustrazioni reali che poi dalla politica estera, finivano inevitabilmente per ripercuotersi negli ambiti interni, generando quella instabilità che è uno dei marchi di fabbrica della zona, oltre all’odio confessionale di cui il simbolo più evidente resta il muro che separa Israele e Palestina edificato a partire dalla primavera del 2002 e lungo circa 730 km.
Com’era facilmente immaginabile, queste tensioni hanno fatto capolino anche nel calcio che per l’ennesima volta si dimostra uno strumento di soft-power, nonché emanazione della politica dei vari stati. Senza addentrarci troppo in una cronologia ricca di aneddoti e restando agli ultimi episodi, basterebbe ricordare le dichiarazioni dell’asso egiziano del Liverpool Mohamed Salah reo, tra le altre cose, di essersi rifiutato di stringere la mano ai calciatori del Maccabi Tel-Aviv quando indossava la maglia del Basilea in una gara valida per il terzo turno dei preliminari di Champion’s League del 2013, o le dichiarazioni più recenti sempre dello stesso calciatore che nel 2018 disse, neanche tanto velatamente, che se i reds avessero acquistato l’israeliano Dabbur, avrebbe chiesto la cessione. Atteggiamenti questi che fanno il paio con quelli della Federcalcio egiziana che di fatto vieta il tesseramento di calciatori col passaporto israeliano.
Tuttavia, sarebbe errato supporre che tali chiusure siano unidirezionali, perché dal canto suo, anche Israele non è immune a torsioni autoritarie declinate in senso calcistico. Basterebbe prendere in considerazione le crescenti difficoltà che affrontano i componenti della nazionale palestinese ogniqualvolta devono ottenere il visto necessario per uscire dal paese e disputare le partite con la propria nazionale (recentemente, nel 2019, per gli stessi motivi anche la finale della “Palestine Cup”, quindi tra due squadre palestinesi – il Markez Belata e il Khadamat Rafah rispettivamente della West Bank e della striscia di Gaza è stata rinviata di mesi falsandone inevitabilmente l’esito) e, cosa tutt’altro che rara a queste latitudini, a volte si è arrivati addirittura all’arresto dei migliori calciatori della selezione, con motivazioni poco credibili e con la negazione dei diritti basilari, quali la possibilità di conferire col proprio legale, la motivazione dell’arresto e la data del processo. D’altronde la penuria di beni, risorse e giustizia sociale in Palestina ha dei chiari riflessi anche nel calcio, basti pensare che a Gaza ci sono non più di una ventina di campi di calcio a fronte di una popolazione che ha superato i cinque milioni.
In ogni caso, come sostenuto in precedenza, in circostanze come queste, il calcio non è altro che un’ulteriore modalità indiretta per fare politica e risente delle contingenze esterne, sebbene dotato della possibilità di avere sviluppi imprevedibili. Così, nel mosaico mediorientale, tutt’altro che alieno a riposizionamenti e cambiamenti di linea, come se fosse una partita a risiko in cui adesso sembra (il condizionale è d’obbligo) che a rimanere col cerino in mano sia l’Iran in qualità di unico sostenitore oltranzista della causa palestinese, anche dei nemici storici dello Stato d’Israele come gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, stanno usando il calcio come termometro delle relazioni internazionali. Infatti, anche in questo specifico ambito si possono scorgere dei segnali di avvicinamento che fanno il paio con gli storici accordi di normalizzazione firmati dagli stati in questione e che si traducono in “trame” calcistiche dai molteplici risvolti.
Da un lato, sembra assodata l’intenzione di alcuni uomini d’affari degli Emirati Arabi Uniti di investire nelle squadre israeliane. Sembra infatti molto più di una semplice voce l’interesse di alcuni di essi ad acquisire quote dell’Hapoel Tel-Aviv; non a caso un membro della dirigenza del club ha dichiarato di essere in contatto con Khaled Al-Qassami – noto investitore degli EAU – facendo riferimento alla storia dell’Hapoel come esempio di collaborazione tra ebrei e musulmani dentro e fuori il rettangolo verde. Ma, da questo punto di vista, la notizia che fa davvero scalpore è la comunicazione da parte del presidente del Beitar Gerusalemme, Moshe Hogeg, di volersi recare di persona negli Emirati Arabi per discutere sull’eventuale ingresso di soci. Lo scalpore è dovuto alla reputazione della tifoseria organizzata del club che si coagula intorno al gruppo “La Familia” di destra estrema e razzista – con cui Hogeg sta conducendo una battaglia sin dal suo insediamento alla guida del club nel 2018 – che è già sul piede di guerra e afferma con fierezza di non essere mai stata infettata dal sangue musulmano (è stato girato anche un documentario su questo gruppo che si intitola, non a caso “Forever Pure” che ripercorre le gesta tutt’altro che edificanti del gruppo) e tramite un comunicato ha ribadito di aborrire l’idea di Hogeg sostenendo che il proprio club è l’unico a potersi fregiare di avere come simbolo sullo stemma la “menorah” ebraica, il tipico candelabro a sette braccia che verrebbe disonorato da una tale scelta e che ci sono cose più importanti dei soldi. Non va dimenticato a tal proposito che “La Familia” si è distinta nelle recenti manifestazioni di piazza a sostegno del Premier Benjamin Netanyahu, accusato di corruzione, durante le quali, oltre ad azioni violente sono stati levati dei canti-shock che inneggiavano a Jigal Amir, colui che nel 1995 assassinò Yitzchak Rabin, e che non più tardi di un anno fa, nel 2019, “La Familia” si era dichiarata pronta a contestare aspramente la società per l’acquisto di un calciatore dal nome “equivoco”, Alì Muhammad senza neanche verificare il fatto che il calciatore in questione fosse un cattolico praticante.
Ma, a prescindere dalle questioni economiche e dirigenziali, per cui comunque bisognerà attendere i tempi tecnici opportuni per vedere se andranno in porto o meno, un primo grosso segnale di distensione anche in ambito calcistico, è stato l’invito per una partita amichevole da parte dell’Hapoel Beer Sheva allo Shabab al-Ahli Dubai. Mentre sulla rotta opposta, si è fatto ancora di più e il passo percorso è stato addirittura enorme, trattandosi del tesseramento dell’attaccante israeliano Dia Saba che dal club cinese Guagzhou R&F all’Al Nasr SC di Dubai – così come sembra che diversi club siano interessati a Beram Kayal centrocampista della nazionale israeliana, ora in forza al Brighton. Si tratta del primo calciatore israeliano a giocare in quel campionato ed è davvero un passo epocale, uno dei tabù più impensabili da poter sfatare fino a pochissimo tempo fa, la cui importanza potrebbe finire per dare un’accelerazione non tanto alle relazioni diplomatiche tra gli stati in questione, ma alla reciproca accettazione dell’altro da parte della popolazione, cresciuta ineluttabilmente a pane e odio verso il nemico. Senza dimenticare che un intensificarsi dei rapporti e delle trattative di mercato tra le leghe dei paesi in questione, potrebbe schiudere le porte del calcio europeo a tanti calciatori arabi, provocando un vero e proprio upgrade per il movimento calcistico locale.
Ma, come l’esperienza ci ha insegnato, non tutto è scontato e ancor di meno è rose e fiori, in fin dei conti molto dipenderà dal rendimento in campo dei calciatori in questione.
Allo stesso tempo, per dei confini concettuali che si assottigliano, altri invece si inspessiscono sempre a causa del calcio. È il caso del roccioso difensore della nazionale palestinese (con cui vanta cinquantasette presenze) classe 1993 Abdallah Jaber, tesserato nell’ultima sessione di calciomercato da parte dell’Hapoel Hadera dopo sette stagioni disputate nel campionato cis-giordano, suddivise tra Hilal Al-Quds e Ahli Al-Khalil.
Jabber è un arabo-israeliano dotato di doppio passaporto – così come altri tre suoi compagni di nazionale: Shadi Shaban, Rami Hamadeh e Mohamed Darweesh – essendo nato a Taibeh, tra la città israeliana di Netanya e quella palestinese di Nablus, ma contrariamente a quanto siamo abituati a leggere, in questo caso il doppio passaporto non è stato d’aiuto per lo sviluppo della propria carriera e per aggirare le lungaggini burocratiche, anzi, tutt’altro. Infatti a causa del passaporto israeliano, la Federcalcio egiziana annullò il suo trasferimento all’Al Mukawloon del 2016 e adesso oltre a una campagna mediatica farcita da insulti, ingiurie e minacce di morte sui social da parte dei tifosi, è arrivata la decisione della federazione palestinese di escludere Jabber dalle sue rappresentative, che ha gettato il difensore nello sconforto. A un’emittente televisiva israeliana – “Canale 13” – il nuovo acquisto dell’Hapoel Hadera ha dichiarato di trovarsi davanti a una situazione surreale in base alla quale per i palestinesi lui non sarebbe un vero arabo, mentre per gli israeliani non può essere e non sarà mai considerato uno di loro.
D’altronde questa è l’altra faccia del calcio e di fronte a situazioni profondamente asimmetriche come quella che intercorre tra Israele e Palestina, il più debole cerca di rivalersi come può e sarebbe anche deontologicamente scorretto utilizzare un metro di paragone univoco di fronte a uno squilibrio nelle relazioni così lampante. Pertanto se per quello che riguarda le relazioni tra Israele e le c.d. petromonarchie ci si può auspicare che il calcio funga da volano per un miglioramento delle relazioni quotidiane, di contro per quello che riguarda i rapporti tra israeliani e palestinesi all’insegna dell’odio atavico, il calcio potrà essere solo il riflesso di una situazione ben più tesa e delicata che, tutti ci auguriamo trovi una risoluzione al più presto all’insegna del reciproco riconoscimento e della pace e l’armonia tra i popoli.